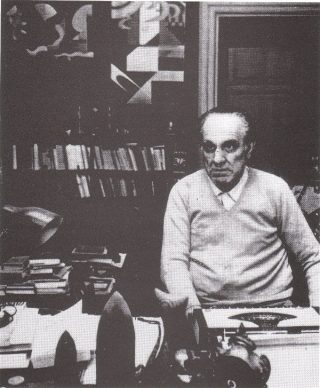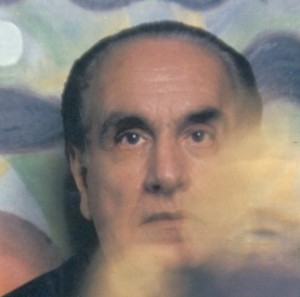VOLTI DELL’EROISMO
Un punto sul quale spesso abbiamo richiamato l’attenzione, e che anche in un’indagine circa la «razza interna» ha la sua importanza, si lega al fatto che, oltre al morire e al combattere, devesi considerare un diverso «stile», una diversa attitudine e un diverso significato propri, volta per volta, alla lotta e al sacrificio eroico. Anzi, in genere, si può parlare, qui, di una scala, varia à seconda dei casi, con cui vien misurato il valore della vita umana. Proprio le vicende di questa guerra mettono a nudo, nel riguardo, dei contrasti, che qui vorremmo succintamente lumeggiare. Ci limiteremo essenzialmente a dei casi-limite, rappresentati, rispettivamente, dalla Russia e dal Giappone.
SUB PERSONALITA’ BOLSCEVICA
Che la condotta di guerra della Russia sovietica non tenga in minimo conto della vita umana e dell’umana personalità, è cosa ormai ben risaputa. Qui i combattenti sono ridotti ad un vero «materiale umano», nel senso più brutale di questa sinistra espressione, purtroppo divenuta ormai corrente in certa letteratura militare: un materiale, per il quale non si deve avere alcun riguardo e che quindi non si deve esitare a sacrificare nel modo più spietato dovunque se ne abbia a sufficienza. In genere, come è stato anche recentemente rilevato, il Russo ha saputo andar sempre con facilità incontro alla morte per una specie di innato, cupo fatalismo e già da tempo in Russia la vita umana aveva un basso prezzo. Ma nell’uso attuale del soldato russo come la più brutta “carne da cannone” si ha anche una logica conseguenza della concezione bolscevica, la quale nutre il più radicale disprezzo per ogni valore della personalità, vuol liberare il singolo da quella superstizione e da quel «pregiudizio borghese» che sarebbero l’io ed il mio, intende ridurlo a membro meccanizzato di un insieme collettivo, esso solo considerato vitale cd importante. Su tale base, si delinea la possibilità di una forma, che noi diremmo «tellurica» e subpersonale di sacrificio e di eroismo: nel segno dell’uomo collettivo onnipotente e senza volto. La morte sul campo dell’uomo bolscevizzato rappresenta per tal via l’estrema fase di quel processo di spersonalizzazione e di distruzione di ogni valore qualitativo e personale, che già sta alla base dell’ideale bolscevico di «civiltà». Qui può realizzarsi davvero ciò che, in un libro tristemente famoso, Erich Maria Rcrnarque aveva tendenziosamente dato come significato complessivo della guerra: la tragica irrilevanza del singolo in una vicenda, nella quale puri istinti, forze elementari scatenate, impulsi subpersonali vanno a prendere il sopravvento su qualsiasi valore e su qualsiasi ideale. Anzi, questa tragicità non è nemmeno sentita, appunto perché il senso della personalità è già spossato, ogni orizzonte superiore è precluso, la collettivizzazione anche spirituale ha già messo profonde radici in una nuova generazione di fanatici, educata al verbo di Lenin e di Stalin. Si ha così una forma precisa, anche se per la nostra mentalità europea quasi incomprensibile, di prontezza a morire e a sacrificarsi, forse perfino presso ad una sinistra gioia per la distruzione propria ed altrui.
LA MISTICA NIPPONICA DEL COMBATTERE
Episodi recenti della guerra giapponese hanno fatto conoscere uno «stile» del morire, che pertanto sembra aver affinità con quello dell’uomo bolscevico, per testimoniare, in apparenza, un uguale disprezzo per il valore del singolo e, in genere, della personalità. Si sa, infatti, di aviatori giapponesi che, deliberatamente, col loro carico di bombe, si sono gettati sul bersaglio, di uomini-mine predestinati a morire nella loro azione e sembra perfino che in Giappone sia stato organizzato da tempo un corpo preciso di questi «volontari della morte». Di nuovo, s’incontra, qui, qualcosa di poco comprensibile per la mentalità occidentale. Tuttavia, se noi cerchiamo di penetrare nel suo più intimo senso questa forma estrema di eroismo, troviamo valori che rappresentano la perfetta antitesi dell’eroismo tellurico» e senza luce dell’uomo bolscevico. Le premesse, infatti, qui sono di carattere rigorosamente religioso, anzi diremmo meglio ascetico e mistico. E ciò non si deve intendere nel senso più noto ed esteriore, in relazione, cioè, con l’idea, che in Giappone l’idea religiosa e l’idea imperiale fanno tutt’uno sì che il servizio per l’Imperatore s’identifica ad un servizio divino e il sacrificarsi per il Tenno e per lo Stato ha lo stesso valore del sacrificio di un missionario o di un martire, ma in senso assolutamente attivo e combattivo. Questi, son certo aspetti dell’idea politico-religiosa nipponica: tuttavia gli ultimi e più intimi punti di riferimento vanno cercati più in alto, nella visione del mondo e della vita propria del buddhismo e soprattutto alla scuola Zen, la quale è stata giustamente definita la «religione del samurai», cioè della casta propriamente guerriera nipponica. Una siffatta visione del mondo e della vita cerca essenzialmente di spostare il sentimento di sè su di un piano trascendente, tanto da relativizzare il significato e la realtà del singolo e della sua vita terrena. Primo punto: il sentimento di « venir da lontano » —la vita terrestre non è che un episodio, essa né comincia nè finisce qui, ha cause remote, è tensione di una forza che ancora si proietterà in altri destini, fino alla liberazione suprema. Secondo punto: in relazione a ciò, si nega la realtà dell’io, quale io semplicemente umano. La «persona» torna ad avere il significato che questo termine ebbe originariamente in latino, ove essa voleva dir maschera di attori, cioè un dato modo di apparire, una manifestazione. Dietro ad essa, secondo lo Zen, cioè secondo la religione del samurai, vi è qualcosa di inafferrabile e di indomabile, di infinito, suscettibile di assumere infinite forme, sì che simbolicamente vien designato come cunya, vale a dire «vuoto», in opposto a tutto quel che è consistente materialmente e vincolato ad una forma. Su tale base si delinea il senso di un eroismo, che può dirsi senz’altro «superpersonale» — quanto quello bolscevico era, invece, «subpersonale». Si può prendere la propria vita e gettarla, nell’estremo della stia intensità, per sovrabbondanza, nella certezza di un’esistenza eterna e della indistruttibilità di ciò che, non avendo avuto principio, nemmeno può avere una fine. Ciò che può sembrare estremo per certa mentalità occidentale, diviene qui naturale, chiaro, evidente. Non si può nemmeno parlare di tragedia — ma nel senso opposto che nel bolscevismo: non si può parlar di tragedia appunto per il senso vissuto della irrilevanza del singolo o per il possesso di un significato e di una forza che, nella vita, va di là dalla vita. E’ un eroismo, che quasi potremmo chiamare “olimpico”. E qui, di passaggio, sia notata la dilettantesca banalità di chi ha cercato di dimostrare, con quattro righe da articolo, il carattere deleterio che vedute simili. direttamente opposte a quelle di chi suppone che l’esistenza terrena sia unica e irrevocabile, avrebbe per ogni idea di Stato e di servizio allo Stato. Il Giappone rappresenta appunto la più fragrante smentita” di simili elucubrazioni, e la veemenza con cui, al nostro fianco, il Giappone conduce una lotta eroica e vittoriosa dimostra invece l’enorme potenziale guerriero e spirituale che può parimenti procedere da un sentimento vissuto della trascendenza e della superpersonalità come quello già detto.
LA “DEVOTIO” ROMANA
Qui viene anzi da sottolineare che, se all’Occidente moderno è proprio il riconoscimento dei valori della persona, ad esso peraltro è propria anche una accentuazione quasi superstiziosa dell’importanza della vita terrena, che poi, democratizzandosi, doveva dar luogo ai famosi «diritti dell’uomo» e ad una serie di superstizioni sociali, democratiche ed umanitarie. Come controparte di questo aspetto non certo positivo, si è avuta una eguale accentuazione della concezione “tragica”, per non dire «prometeica», cosa che egualmente equivale ad una caduta di livello. Dobbiamo, di contro a ciò, ricordare gli ideali «olimpici» delle nostre più antiche e schiette tradizioni; e per tal via potremo allora comprendere come cosa parimenti nostra un eroismo aristocratico, libero da passione, proprio ad esseri, il centro della vita dei quali sta veramente su di un piano superiore, dal quale si lanciano, di là da ogni tragedia, da ogni vincolo, da ogni angoscia, come forze irresistibili. Qui ci vien da fare una breve rievocazione storica. Benché a pochi sia noto, le antiche tradizioni nostre romane, presentano motivi affini a quelli del dono eroico a fondo perduto della propria persona in nome dello Stato e ai flni della vittoria, che abbiamo visti apparire anche nella mistica giapponese del combattere. Alludiamo alla cosiddetta devotio. I presupposti di essa sono parimenti sacrali. Vi agisce anzi la persuasione generale dell’uomo tradizionale, che forze invisibili sono in atto dietro a quelle visibili e che all’uomo, a sua volta, è possibile influire su di esse. Secondo l’antico rito romano della devotio, quale noi l’abbiamo in vista, un guerriero e soprattutto un Capo può facilitare la vittoria mediante un misterioso scatenamento di forze determinato dal sacrificio deliberato della sua persona, da attuarsi con la volontà di non uscire vivo dalla mischia. Si ricorda l’esecuzione di questo rito da parte del console Decio nella guerra contro i Latini (340 a.C.), come pure la ripetizione di esso — esaltata da Cicerone (Fin. Il 19, 61; Tusc. I. 37, 39)- da parte di altri due rappresentanti della stessa famiglia. Il rito aveva perfino un suo preciso cerimoniale, testimoniante la perfetta consapevolezza e lucidità di questa offerta eroico-sacrificale. Secondo l’ordine gerarchico, venivano anzitutto invocate le divinità olimpiche dello Stato romano, Giano, Giove, Quirino, subito dopo il dio della guerra, Pater Mars, poi gli dèi indigeti, «dèi — è detto — che avete potenza sugli eroi e sui nemici»; in nome del sacrificio che ci si propone di compiere, si invocava di «conceder forza e vittoria al popolo romano dei Quiriti e di travolgere con terrore, spavento e morte i nemici del nostro popolo» (cfr. Livio, VIII, 9). Proposte dal pontifex, le parole di questa formula vengono pronunciate dal guerriero, rivestito dalla praetesta, con un piede su di un giavellotto. Dopo di che, egli si lancia nella mischia, per morire. Di passaggio, sia qui notata la trasformazione del senso della parola devotio. Applicata originariamente a quest’ordine di idee, cioè ad una azione eroica, sacrifìcale ed evocatoria, essa nel basso Impero andò a significare la semplice fedeltà del cittadino e perfino la scrupolosità nel pagamento del fisco (devotio rei annonariae). Secondo le parole del Bouché Lequerq, alla fine, ~sostituitosi al Cesare il Dio cristiano, la devotio significa semplice religiosità, la fede pronta a tutti i sacrifici e poi, per una ulteriore degenerescenza dell’espressione, la devozione nel senso abituale della parola, cioè una preoccupazione costante per la salvezza, affermata in una pratica minuziosa e timorata del culto». Ciò a parte, nell’antica devotio romana abbiamo dunque segni ben precisi di una mistica consapevole dell’eroismo e del sacrificio, presso ad una stretta connessione fra il sentimento di una realtà sovrannaturale e super-umana e la lotta e la dedizione in nome del proprio Capo, del proprio Stato e della propria razza. Né mancano testimonianze circa un sentimento «olimpico» del combattere e del vincere proprio alle nostre antiche tradizioni. Di ciò, ci siamo occupati estesamente altrove. Ricordiamo solo che nella cerimonia del trionfo il duce vittorioso assumeva a Roma appunto le insegne del dio olimpico, ad esprimere la vera forza che in lui aveva determinato la vittoria; ricorderemo ancora che di là dal Cesare mortale la romanità venerò il Cesare come un «vincitore perenne», cioè come una specie di forza superpersonale dei destini romani. Così, se i tempi successivi hanno fatto prevalere altre vedute, pure le tradizioni più antiche ci dimostrano che l’ideale di un eroismo «olimpico» è stato anche un nostro ideale, che anche la nostra gente ha conosciuto l’offerta assoluta, la consumazione di tutta una esistenza in una forza scagliata contro il nemico fino al limite di evocazione di forze abissali; una vittoria, infine, che trasfigura e propizia partecipazioni a potenze superpersonali e «fatali». Così anche sulla base di un retaggio nostro si delineano punti di riferimento in radicale opposizione all’eroismo subpersonale e collettivistico in principio indicato, non solo, ma anche ad ogni visione tragica ed irrazionalistica, che ignora quel che è più forte di fuoco e ferro, di morte e di vita.
IL DIRITTO SULLA VITA
Intendiamo, qui, trattar brevemente non del diritto sulla vita in genere, bensì del diritto sulla propria vita, secondo la trasposizione dell’antica formula jus vitae necisque, che qui dunque equivarrebbe alla potestà di accettare l’esistenza umana ovvero di por fine volontariamente ad essa. Questo problema intendiamo considerano dal punto di vista puramente spirituale, perciò di là da considerazioni di carattere sociale, considerazioni che —in questo come in qualsiasi altro campo — possono avere un peso reale solo quando siano confortate da una persuasione sorta nel proprio foro interiore, da veri principi e da un senso superiore di responsabilità. Questa responsabilità si deve dunque intenderla essenzialmente di fronte a se stessi e, invero, non restringendosi agli angusti orizzonti della vita individuale, ma considerando il senso generale del proprio destino terrestre e superterrestre. Dalle nostre considerazioni terremo parimenti lontano ogni riferimento di carattere devozionale, dato il piano assai condizionato e poco illuminato che di solito vi si riferisce. Vorremmo invece tenerci fedeli ai criteri di un realismo di carattere superiore.
LA VEDUTA DI SENECA
Su tale piano, la forma più severa e virile nella quale è stato affermato il diritto assoluto di disporre della propria vita terrestre si riferisce allo stoicismo, specie nelle formulazioni di Seneca, le vedute fondamentali del quale risentono — a parere di molti — di uno spirito tipico non solo romano, ma anche ano-roma-no, per quanto limitato da un certo irrigidimento e da una certa esasperazione. Per intendere la portata della veduta di Seneca e, in generale, la essenza delle idee che qui vogliamo esporre, bisogna cominciare col condannare senz’altro qualsiasi giustificazione del diritto di togliersi la vita, in cui intervenga un motivo passionale. L’uomo che si uccide mosso da una qualsiasi passione è da condannare e da disprezzare, perché è un vinto, un caduto. Il suo atto testimonia solo la sua passività, la sua incapacità di riaffermarsi di fronte agli impulsi di quel-la Vita sensitiva, porsi al disopra della quale è la prima condizione per potersi considerare come davvero uomo. Su tali casi, non è dunque necessario dedicare ulteriori parole. La giustificazione di Seneca del diritto di uccidersi è interessante, perché si pone decisamente di là da un tale piano. La visione generale della vita di Seneca e dello stoicismo romano è quella di una lotta e di una prova. Secondo Seneca, l’uomo vero sta al disopra degli stessi dèi perché questi, per natura, non sono esposti ad avversità e sciagure, l’uomo invece è ad esse esposto, ma ha il potere di trionfare. Infelice è colui che mai ha incontrato la sciagura e il dolore — dice Seneca — perché costui non ha avuto occasione di sperimentare e di conoscere la propria forza. Agli uomini è stato concesso qualcosa di più che l’esser esenti dai mali; la forza di trionfare su di essi. E le persone più colpite vanno considerate come le più degne, così come le posizioni più esposte e difficili e le missioni più pericolose in guerra sono affidate agli elementi più forti e qualificati, laddove i meno coraggiosi, i meno forti e gli infidi sono usati nella vita meno disagiata delle retrovie. Ora, presso alla più precisa affermazione di una simile visione virile e combattiva della vita Seneca giustifica l’uccidersi. La giustificazione la mette perfino sulla bocca della divinità (De providentia, VI, 7-9), la quale dice non solo di aver accordato all’uomo vero, al saggio, una forza più forte di ogni contingenza, ma di aver fatto sì che nulla possa trattener l’uomo quando più non voglia: la via per «uscire» è aperta — pater exitus. «Dovunque non vogliate combattere, vi è sempre possibile ritirarvi. Nulla vi è stato dato di più facile che morire».
INSEGNAMENTI ARII
L’espressione si pugnare non vultis, licet fugere, con allusione alla morte volontaria che il saggio avrebbe diritto di dare a se stesso, nello spirito del testo, non va intesa come una vigliaccheria, in quanto fuga. Non si tratta di ritirarsi, perché non ci si sente abbastanza forti di fronte ad una data prova. t piuttosto un averne abbastanza di un giuoco di cui alla fine non si comprende più il senso, dopo aver mostrato a se stessi di aver la capacità di superare prove consimili. ~ dunque un distacco freddo, quasi diremo olimpico, fatto da persona che non ha cessato di dominare tutti gli elementi della vicenda. Nelle antiche tradizioni arie si trovano giustificazioni dell’”uscire” volontariamente dalla vita terrestre non prive di una certa affinità con la veduta, ora esposta, dello stoicismo romano. Dovunque si è portati a rinunciare alla vita in nome della vita, cioè per una forma o per un’altra di una volontà di vivere o di godere che non può trovare il suo appagamento, si riprova l’uccidersi. In tali casi, questo atto non significa una liberazione, ma proprio il contrario, la forma estrema, seppure negativa, di attaccamento alla vita, di dipendenza dalla vita e dal «desiderio». Nessun «aldilà» attende chi usa una tale violenza su se stesso; la legge di una esistenza priva di luce, di pace e di stabilità si riaffermerà ancora una volta su di lui. Avrebbe invece diritto di por fine prematuramente alla sua vita terrestre solo chi avesse realizzato un pieno distacco di fronte a tale vita, tanto da essergli divenuti, il vivere o il non-vivere, cose affatto uguali. Ma allora si potrebbe appunto domandare, che cosa muova una persona giunta a tale apice, ad assumere l’iniziativa di una tale soluzione violenta. Ciò, di tanto più, che chi ha raggiunto una tale perfezione difficilmente non ha anche colto, in una qualche misura, il significato superpersonale della sua esistenza in terra, sentendo, in pari tempo, che l’insieme di questa stessa esistenza non è che un breve transito, un episodio, l’apparire per una data missione o prova particolare, «un viaggio durante le ore di notte», come dicono gli Orientali. L’avvertire un qualsiasi tedio, una qualsiasi impazienza, una insofferenza per il tempo che ancora ci sta dinanzi non testimonierebbe forse un residuo umano, una debolezza, qualcosa di non ancor «risolto» e placato dal senso dell’eternità, o, almeno, delle «grandi distanze» non-terrene e non-temporali?
E’ “MIA” LA VITA?
Ciò a parte, vi è un’altra considerazione di principio da fare. Si può aver veramente diritto solo su ciò che ci appartiene. Il diritto di por fine alla propria vita è quindi condizionato dalla misura in cui questa vita possa esser detta davvero «mia». E parlando di «vita» non si può non riferirsi anche al corpo, all’organismo fìsico-psichico in genere, sul quale appunto si deve agire per «finirla»; né si deve escludere la stessa vita dei sentimenti e delle sensazioni. Ora, in via assoluta, può dirsi tutto ciò davvero «mio» e «me stesso»? Qui ognuno si fa delle illusioni, che tuttavia un istante di riflessione basta a dissipare. Un testo della tradizione aria, cui si è già accennato, pone il problema in modo molto tangibile in un dialogo. Il savio domanda: «Un sovrano ha forse potere di far giustiziare, bandire o graziare chi vuole nel suo regno?» — “Certamente”. «Che pensi tu allora, che dici così: Il corpo è me stesso, ti si può compiere questo desiderio: Così deve essere il mio corpo, così non deve essere il mio corpo? E ancora: tu che dici: La sensazione è me stesso, la percezione è me stesso, ti si può compiere il desiderio: Così deve essere la mia sensazione o percezione, così essa non deve essere?». La risposta dell’interrogato deve essere per forza negativa. Non si può dunque parlar di «mio corpo», di «mia vita», perché allora dovrebbe trattarsi di cose su cui io ho potere, mentre di fatto un tale potere o è nullo, o è minimo. Non si è il principio e la causa della «nostra» vita, che noi invece riceviamo, sì che nelle antiche tradizioni arie essa vien considerata come un «prestito» da pareggiare col dovere di restituire ad altro tale vita, generando un figlio. Ed anche per questo il primogenito fu chiamato «il figlio del dovere». Del resto, là dove la vita fosse noi stessi e cosa nostra, dovrebbe esser possibile dipartirsi dall’esistenza terrestre per mezzo di un puro atto dello spirito o della volontà, senza azioni violente esteriori: cosa impossibile alla quasi totalità degli uomini, perché solo qualche tradizione antica considerò una «uscita» del genere, riferendola pertanto a figure assolutamente d’eccezione. Uccidendosi nel modo comune, fisico, si fa perciò violenza su cosa che non può dirsi nostra e che non dipende da noi: su cosa, dunque, sulla quale non può dirsi, secondo giustizia, di aver «diritto» – Ius vitae necisque: già meno che sui propri figli, perché questi, almeno, sono stati generati da noi. Qui tuttavia può presentarsi una obbiezione. Si può dire che, appunto perché noi non abbiamo voluto e creato la nostra vita, non siamo tenuti ad accettare o a conservare in tutti i casi un tale prestito o dono. Ad un certo momento si può dunque farla finita. Qui, naturalmente, dovrebbesi presupporre realizzata la condizione già accennata, vale a dire, quella di un distacco di sé dalla vita stessa, da dimostrare a se stessi con prove positive e non con semplici parole o con suggestioni. Altrimenti già il considerar la vita come cosa estranea che si può conservare o rimettere a chi, senza il nostro consenso, ce l’ha data, sarebbe una semplice finzione mentale. Si resta dunque sempre nel dominio di casi eccezionali. In ordine ad essi, che vi sarebbe da pensare?
PROVE DI REAZIONE SUL DESTINO
La soluzione della difficoltà è condizionata dalle vedute che si hanno in fatto di visione generale del mondo. La gran parte degli uomini occidentali moderni, per via della religione predominante si sono abituati a considerare nella nascita fisica il principio della loro vita. Per costoro il problema, naturalmente, è abbastanza grave, perché là dove la nascita e quindi la vita terrestre non sono considerate come effetto di un caso o di un incontro di circostanze esterne, essa e riferita alla volontà divina. Nell’un caso come nell’altro la volontà propria no~’ vi entra per nulla, per cui, là dove non si sia abbastanza religiosi per accettare la propria vita per amor di Dio, in rassegnazione e in ubbidienza, si può sempre riallermare l’atteggiamento di colui che rivendica la propria libertà di fronte a cosa, che egli non ha voluta. Ma la veduta della gran parte delle più antiche tradizioni indo-europee non coincide con quella ora accennata. Di massima veniva una preesistenza rispetto alla vita terrena e un rapporto di causa e d’effetto, talvolta perfino d’elezione, tra la forza preesistente alla nascita fisica e questa stessa vita. La quale, in tal caso, pur non potendo essere attribuita alla volontà più esteriore e già umana del singolo, va a rappresentare un ordine compenetrato di un determinato senso, qualcosa che — sia pur riposto — ha un suo significato per l’Io, come una serie di esperienze importanti non in se stesse, ma riguardo alle nostre reazioni. In una parola, allora la Vita quaggiù non è più un caso, epperò non può considerarsi né come cosa da accettare o respingere ad arbitrio, né come una realtà che ci si impone, di fronte a cui si è solo passivi, col divario di una rassegnazione ottusa ovvero di una continua prova di resistenza. Sorge invece la sensazione che la vita terrestre è qualcosa, in cui noi, prima di essere uomini terrestri, ci siamo, per cosi dire «compromessi» ed in una certa misura impegnati, sia — se si vuole — come in un’avventura, sia come in una missione o in una elezione, assumendo in blocco anche aspetti problematici e tragici di essa. t difficile che quella superiorità o, anche, semplicemente quel distacco di fronte alla vita, che permetterebbe di gettarla, non si accompagni — come gia accennammo — ad un significato del genere dell’esistenza: il quale però in ben pochi casi farebbe comprendere la decisione di «finirla». Ognuno sa che prima o poi questa fine verrà, sì che di fronte ad ogni contingenza l’attitudine più saggia sarebbe di scoprirne il significato nascosto, la parte che essa ha in tutto, che in fondo — secondo la veduta accennata —si incentra in noi e(l è contenuto con un nostro volere trascendentale. E là dove fosse decisiva — sinceramente — solo una impazienza per l’eterno, per l’esistenza non più terrena, sì da far vera la frase mistica spagnola: in tam alta vida espero, que muero porquè no muero (spero in una così alta vita, da morire di non poter morire), si esasperi la vita come prova, Invece di passare ad un intervento diretto e violento: vi sono le vicende eroiche di una guerra, vi è l’alta montagna, vi è una vita pericolosa in esplorazioni o in missioni — vi sono mille possibilità per porre al «destino» una domanda più perentoria cd insistente cd aver dalle cose stesse la risposta della misura, in cui esiste ancora una ragione profonda, impersonale, del continuare qui una vita umana.
FEDELTÀ ALLA PROPRIA NATURA
Oggi quanto mai bisognerebbe persuadersi, che anche i problemi sociali, nell’essenza, rimandano sempre a problemi etici e di visione generale della vita. Chi pensa di risolvere i problemi sociali su di un piano puramente tecnico, rassomiglierebbe ad un medico che s’intendesse unicamente a combattere i sintomi epidermici di un male, invece di indagare e colpirne la radice profonda. La gran parte delle crisi, dei disordini, delle disequazioni che caratterizzano la società occidentale moderna se, in parte, dipendono da fattori materiali, almeno in egual misura dipendono anche dal silenzioso sostituirsi di una visione generale della vita ad un’altra, da una nuova attitudine rispetto a se stessi e al proprio destino, che è stata celebrata come una conquista, laddove essa rappresenta una deviazione e una degenerescenza. Per l’ordine di cose che qui intendiamo trattare, è di particolare rilievo l’opposizione esistente fra l’etica moderna «attivistica» e individualistica e la dottrina tradizionale ed aria relativa alla (natura propria». In tutte le civiltà tradizionali — in quelle che la vuota presunzione «storicistica» considera «superate» e che l’ideologia massonica giudica «oscurantistiche» —il principio di una fondamentale uguaglianza della natura umana fu sempre ignorato e fu considerato come una visibile aberrazione. Ogni essere ha, con la nascita, una “natura propria”, il che equivale a dire un suo volto, una sua qualità, una sua personalità, anche se più o meno differenziata. Secondo i più antichi insegnamenti arii ed anche classici, in ciò non veniva del resto veduto un «caso», ma vi si presentiva l’effetto di una specie di elezione o di determinazione anteriore allo stesso stato umano di esistenza. In ogni modo, la constatazione della «natura propria» non fu mai quella di un destino. Si nasce incontestabilmente con certe tendenze, con certe vocazioni ed inclinazioni, talvolta senz’altro palesi e precise, tal’altra latenti e tali da manifestarsi solo in particolari circostanze o prove. Di fronte a questo elemento differenziato innato, legato alla nascita se non pure — come negli insegnamenti già accennati — a qualcosa che vien da lontano, che precede la stessa nascita, ognuno ha un margine di libertà. Ed è qui che si presenta l’opposizione delle vie e delle etiche: di quella tradizionale e di quella «moderna». Il cardine dell’etica tradizionale è esser sé e restar fedeli a se stessi. Ciò che si «è», bisogna riconoscerlo e volerlo, anziché cercar di realizzarsi diversi a quel che si è. Ciò non significa per nulla passività e quietismo. Esser se stessi è sempre, in una certa misura, un compito, un «tener fermo». Implica una forza, una drittura, uno sviluppo. Ma questa forza, questa drittura, questo sviluppo, qui hanno una base, prolungano disposizioni innate, si legano ad un carattere, manifestano tratti di armonia. di coerenza con se stessi, di organicità. L’uomo si avvia, cioè, ad esser «tutto di un pezzo». Le sue energie sono volte a potenziare e ad affinare la sua natura e il suo carattere e a difenderlo contro ogni tendenza estranea, contro ogni influenza alteratrice. E’ così che l’antica saggezza formulò massime, come queste: «Se gli uomini si fanno una norma d’azione non conforme alla loro natura, essa non deve essere considerata come norma d’azione». E ancora: «Meglio il proprio dovere anche se imperfettamente compiuto, che il dovere di un altro bene eseguito. La morte nel compiere il proprio dovere è preferibile; il dovere di un altro ha grandi pericoli». Questa fedeltà al proprio modo d’essere assurse perfino ad un valore religioso: «L’uomo raggiunge la perfezione — è detto in un antico testo ano — adorando colui, dal quale tutti i viventi procedono e tutto questo universo è compenetrato, mediante il compimento del proprio modo d’essere». Ed anche: «Fa sempre ciò che deve esser fatto (in conformità alla propria natura), senza attaccamento, perché l’uomo che agisce in un disinteresse attivo consegue il Supremo». ~ diventato purtroppo tin uso, oggi, inorridire non appena si ricordi il regime delle caste. «Caste?!». Ma oggi non si parla più nemmeno di «classi» e a mala pena di «categorie»! Oggi si fanno saltare i «compartimenti stagni» e si «va verso il popolo»! Simili prevenzioni sono frutto d’ignoranza e al massimo si spiegano col fatto che, invece di considerare i principi di un sistema, ci si ferma a forme deviate, svuotate o degenerescenti di esso. Va notato anzitutto che la «casta» in senso tradizionale non ha assolutamente nulla a vedere con le «classi», queste essendo ripartizioni artificiali su base essenzialmente materialistica, mentre le caste si legavano alla teoria della natura propria e all’etica della fedeltà alla natura propria. Per questa ragione — in secondo luogo — esistette spesso un regime di caste di fatto, in via naturale, senza alcuna statuizione positiva, quindi senza nemmeno che venisse usata la parola «casta» o una parola simile: come in una certa misura fu il caso anche nel Medioevo. Nel riconoscere la propria natura, l’uomo tradizionale riconosceva anche il suo «luogo», la propria funzione e i giusti rapporti di superiorità e di inferiorità. Le caste, o gli equivalenti delle caste, in via di principio, prima di definire dei gruppi sociali, definivano delle funzioni, dei modi tipici di essere e di agire. Il fatto della corrispondenza delle tendenze innate ed accettate e della natura propria dei singoli a queste funzioni determinava la sua appartenenza alla casta corrispondente, di modo che nei doveri propri alla sua casta ognuno poteva riconoscere l’esplicazione normale della sua stessa natura. Per questo nel mondo tradizionale il regime delle caste apparve spesso come una calma istituzionale naturale, fondata su qualcosa che era evidente agli occhi di tutti, e non sull’esclusivismo, stilla sopraffazione o sull’arbitrio di pochi. In fondo, il principio romano ben noto suum cuique tribuere riporta esattamente alla stessa idea: ad ognuno il suo. Gli esseri, essendo disuguali, è assurdo che tutto sia accessibile a tutti, e ognuno, in via di principio, sia atto a qualunque funzione. Ciò implicherebbe una deformazione, uno snaturamento. Le difficoltà che sorgono in coloro che hanno in vista le condizioni attuali, ben diverse da quelle del sistema, di cui si sta parlando, si legano al fatto di rappresentarsi i casi, nei quali il singolo manifesta vocazioni e doti diverse, di quelle del gruppo in cui per nascita e per tradizione si trova. Senonché in un mondo normale simili casi hanno sempre rappresentato una eccezione, e ciò per una ragione precisa: perché a quei tempi i valori di sangue, di razza e di famiglia venivano naturalmente riconosciuti e per tal via si realizzava in larga misura una continuità sia biologico-ereditaria, sia di vocazione, di qualificazioni e di tradizioni. Appunto questa è la controparte dell’etica dell’esser se stessi; il ridurre al minimo la possibilità, che la nascita sia davvero un caso e che il singolo si trovi come uno sradicato, in dissonanza con il suo ambiente, con la sua famiglia se non perfino con se stesso, col proprio corpo e la propria razza. Inoltre, devesi rilevare che il fattore materialistico e utilitaristico in dette civiltà e società era notevolmente ridotto da valori più alti, intimamente vissuti. Nulla appariva cosa più degna che seguire la propria naturale attività, che seguire la vocazione veramente conforme al proprio modo d’essere, per umile o modesta che fosse: tanto, che si poté concepire, che chi si mantiene nel proprio stato e compie in una tale impersonalità e purità i doveri ad esso inerenti, ha la stessa dignità dell’appartenente a qualsiasi casta «superiore»: un artigiano, pari a quella di un membro dell’aristocrazia guerriera o di un principe. Da qui procede anche quel senso di dignità, di qualità e di diligenza che si è palesato in tutte le organizzazioni e professioni tradizionali; da qui, quello stile, per cui anche un fabbro, un falegname o calzolaio non si presentavano come uomini abbrutiti dalla loro condizione ma quasi come dei «signori», come persone che liberamente avessero scelta ed esercitassero quella forma d’attività, con amore, dando ad essa sempre una impronta personale e qualitativa, mantenendosi staccati dalla pura preoccupazione del guadagno e del profitto. Il mondo «moderno» tuttavia, di massima, ha seguìto proprio la via opposta, la via di una sistematica trascuranza della natura propria, la via dell’individualismo, dell’«attivismo» e dell’arrivismo. L’ideale qui non è più l’esser quel che si è, bensì il «costruirsi», l’applicarsi ad ogni specie di attività, a caso, ovvero per considerazioni affatto utilitarie. Non più attuare in seria aderenza, fedeltà e purità, il proprio essere, bensì l’usare ogni forza per divenire quel che non si è. L’individualismo, essendo a base di una tale veduta, cioè l’uomo atomizzato, senza nome, senza razza e senza tradizione, si è avanzata logicamente la pretesa dell’eguaglianza, si è rivendicato il diritto di poter essere, di massima, tutto ciò che un qualsiasi altro può anche essere, e non si è voluto riconoscere alcuna differenza più vera e giusta di quella realizzata da se stessi, artificialmente, nei termini dell’una o dell’altra forma di una civiltà ormai materializzata e secolarizzata. Come è noto, questa deviazione è giunta al limite nei Paesi anglosassoni e puritani. E con essa facendo fronte comune l’illuminismo massonico, la democrazia e il liberalismo, si è giunti ad un punto tale, che a molti ogni differenza innata e naturale appare come un bruto dato «naturalistico», che ogni veduta tradizionale viene giudicata oscurantistica e anacronistica e non si sente l’assurdità dell’idea, che tutto sia aperto a tutti, che si abbiano eguali diritti e eguali doveri, che viga una unica morale, la quale dovrebbe imporsi nella stessa misura e valere per tutti, con piena indifferenza per le singole nature e le differenti intime dignità. Da qui, anche, è ogni antirazzismo, la denegazione dei valori sia del sangue, sia della famiglia tradizionalmente concepito. Sicché a buon diritto qui potrebbe parlarsi, senza eufemismi, di una vera e propria «civiltà» di «fuori casta», di paria gloriantisi di questa loro qualità. ~ proprio nei quadri di una tale pseudo-civiltà che sorgono le classi, le quali non hanno nulla a che fare con le caste, essendo prive di ogni base organica e davvero tradizionale, essendo aggruppamenti sociali artificiali, determinati da fattori estrinseci e quasi sempre materialistici. La classe sorge quasi sempre su base individualistica, vale a dire, è il «luogo» che raccoglie tutti coloro che, col darsi da fare, hanno raggiunto una stessa posizione sociale, con piena indipendenza di quel che essi per natura veramente sono. Questi raggruppamenti artificiali tendono poi a cristallizzarsi, generando allora le tensioni a tutti note. Infatti nella disgregazione propria a questo tipo di «civiltà» si realizza anche la degradazione delle «arti» in semplice «lavoro», si compie la trasformazione dell’antico artefice o artigiano nell’«operaio» proletarizzato, pel quale quel che fa vale unicamente come mezzo di guadagnare, che sa solo pensare a «salari» e «ore di lavoro» e a poco a poco va a destare in sé bisogni artificiali, ambizioni e risentimenti, dato che le «classi superiori», alla fine, non mostrano più ai suoi occhi nessun carattere giustificante la loro superiorità e il loro disporre di una maggior copia di beni materiali. Perciò la lotta di classe è una delle conseguenze estreme di una società che si è snaturata e ha considerato lo snaturamento, la trascuranza della natura propria e della tradizione, come una conquista e come un progresso. Ed anche qui si può considerare un retroscena razziale. L’etica individualistica corrisponde indubbiamente ad uno stato di mescolanza delle genti e dei ceppi, nella stessa misura che l’etica dell’esser se stessi corrisponde invece ad uno stato di prevalente purità razziale. Dove i sangui si incrociano, le vocazioni si confondono, riesce sempre più difficile veder chiaro nei proprio essere, cresce sempre più la labilità interiore, segno della mancanza di vere radici. Gli incroci propiziano il sorgere e il potenziarsi della coscienza dell’uomo come «individuo», favoriscono anche tutto ciò che è attività «libera», «creativa», in senso anarchico, «abilità» furbesca, «intelligenza» in senso razionalistico o sterilmente critico: tutto ciò, a spese delle qualità di carattere, di un affievolimento del sentimento della dignità, dell’onore, della verità, della drittura, della lealtà. Si determina così una situazione anche spiritualmente obliqua e caotica, che però a molti nostri contemporanei sembra normale; per cui, ad essi i casi di individui pieni di contraddizioni, privi del significato del vivere, tali, che essi non sanno più quel che vogliono, fuor che le cose materiali, in contrasto con la propria tradizione, la propria nascita e la loro naturale destinazione, tali casi non appaiono più come anomalie o apparizioni teratologiche, bensì come l’ordine naturale delle cose, che confuterebbe e dimostrerebbe artificiale, assurdo ed oppressivo ogni limite di tradizione, di razza, di nascita. A questa opposizione fondamentale in tema di etica e di visione generale della vita dovrebbero badare, in maggior misura di quanto finora accada, coloro che oggi si occupano di problemi sociali e parlano di «giustizia sociale», se essi debbono veramente venire a capo dei mali contro cui in buona fede combattono. Un principio di rettificazione non si può avere, che là dove l’assurda idea classista sia superata per mezzo di un ritorno dell’etica della fedeltà alla natura propria e quindi ad un sistema sociale ben differenziato ed articolato. Noi abbiamo spesso detto che il marxismo, in molti casi, non è sorto perché esisteva una reale indigenza «proletaria», ma viceversa: è il marxismo che per snaturamento ha creato un ceto operaio «proletarizzato», pieno di risentimento e di ambizioni innaturali. Le forme più esterne del male da combattere si possono curare con la «giustizia sociale», nel senso di una certa più equa distribuzione dei beni materiali; ma della radice interna di esso non si verrà mai a capo, se non si agisce energicamente in sede di visione generale della vita; se non si ridesta l’amore per la qualità, la personalità, la natura propria; se non si restituisce il suo prestigio al principio, disconosciuto solo nei tempi «moderni», di una giusta differenza conforme alla realtà e se da un tale principio non si traggano, su tutti i campi, le giuste conseguenze, anche se con preciso riguardo al tipo di civiltà venuto a prevalere nel mondo moderno.